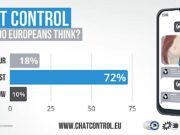L’autore Michael Fray (Londra 1933) prende le mosse da un vero fatto “storico”, un incontro avvenuto nel 1941, quando la Danimarca era occupata dai nazisti, fra il fisico danese di semiorigine ebrea Niels Bohr e l’allievo prediletto, il fisico tedesco di origine ebrea Werner Heisenberg, presente la consorte del maestro, ambedue fisici teorici.
La fisica teorica era una disciplina considerata secondaria rispetto alla fisica sperimentale: per questo motivo il regime tollerava che se ne occupassero gli ebrei. Heisenberg, inventore del principio fisico di indeterminazione, aveva accettato di collaborare con i nazisti per poter proseguire le proprie ricerche.
Per meglio comprendere il testo, si annota che la fisica quantistica nasce dalla crisi della fisica classica (Galileo, Newton), la quale pensava che, se di un corpo si conoscono posizione e velocità (o quantità), se ne può prevedere il futuro comportamento.
Nel 1927 Heisemberg formula il principio di indeterminazione: è impossibile misurare in contemporanea posizione e velocità di un corpo perchè ogni volta che si misura si perturba il sistema.
Nella realtà nessuno sa cosa gli scienziati si dissero davvero: loro stessi vollero conservare il segreto. Ma si sa che Bohr rientrò in casa furioso subito dopo aver iniziato una passeggiata con il suo amico allievo.
La finzione scenica mostra i due scienziati, non più in vita, che parlano di ciò che è stato: l’autore cerca di smagliare il mistero di quel colloquio. Le ipotesi non sono molte e potrebbero sovrapporsi.
Werner avrebbe potuto cercare Niels per sapere a che punto fossero pervenute le ricerche di altri sull’energia nucleare, alias bomba atomica, o per rassicurarlo sul proprio pseudoimpegno in proposito, o per consultarsi su eventuali remore etiche.
Lo spettatore percepisce in sostanza conosciuti dilemmi, se prevalga la scienza o la coscienza, se la prima debba porsi limiti oggettivi, se uno scienziato possa essere al servizio della propria nazione senza porsi problemi di sorta.
Ma la riflessione si estende ad una esplorazione più intimista e poco percepita: ogni volta che si osserva qualcosa la si modifica, il pensiero dell’uomo, la psiche, è indeterminatezza, così come non vi sono certezze sul comportamento di una entità fisica.
Un testo che parte da interrogativi su scienze considerate esatte per far arrivare al dubbio l’uomo della strada ed al tempo stesso renderlo consapevole della sua essenza.
Si propone una tecnica di recitazione d’ arte consumata: trasmettere sensazioni palpabili di elementi della fisica, la luce, l’atomo scisso, mediante la velocizzazione delle parole, che risultano, a tratti, quasi incomprensibili. L’interpretazione di tre attori di razza rende questo spettacolo imperdibile.
I due fisici passeggiano con le parole come passeggiavano per i viali in vita, granitico nordico l’uno, inquieto, vivace ma guardingo l’altro: Margrethe è il moderatore, ora sensato, ora umorale, fra due persone che si parlano da scienziati e da uomini, pur studiandosi e conservando, alla fine, i loro segreti.
Infatti, a Los Alamos, il collaboratore di morte sarà proprio lui, l’insospettabile.
“Copenaghen”, interpretato da Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Giuliana Lojodice, per la regia di Mauro Avogadro, è al Teatro Duse fino a domenica 18 marzo.
Elisa Prato